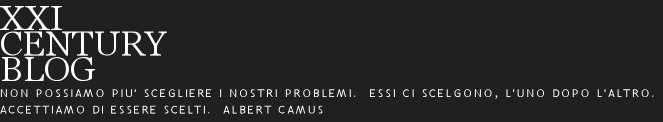La mattina lo svegliò il battito alla porta. Veronique. Erano le nove e Will si era addormentato solo alle cinque e mezza, dopo gli ultimi preparativi. Lei entrò con un sorriso e mentre lui era in bagno a farsi la doccia sedette sul letto e guardò la camera spoglia, senza pensare a nulla perché non voleva piangere. La luce del mattino filtrava attraverso la veneziana. Sul pavimento, le tre valigie aperte, piene di indumenti e libri. Il letto era ancora fatto. Sullo schienale della sedia i vestiti per la giornata.
Si sentì come nell’occhio del ciclone, ieri sera c’erano stati i primi addii, poi questo pomeriggio ce ne sarebbero stati altri, in mezzo la partenza di Will, e questa strana calma, ora, un po’ desolata. Lui tornò dal bagno e si vestì in fretta, scesero a fare colazione insieme e scherzarono come sempre, attorno al tavolo tondo, come se fosse un giorno qualsiasi, come se niente stesse per capitare.
Will era vivace e in vena di battute, sui pancakes, sul caffè schifoso di Starbucks, sul fatto che Rhode Island non è un island, su tutto, su niente. Ma questa euforia oggi aveva qualcosa di poco convincente. Perché non mi succede qualcosa, si disse, sta per andarsene e non la rivedrò più. Perché questo atteggiamento minimalista, io e lei? Mi sento un ghiacciolo.
Alle nove e mezza dovettero andare. Una montagna di bagagli venne trasportata per i corridoi, e insieme raggiunsero l’ascensore. Sul marciapiedi aspettarono un taxi. Al momento di caricare i bagagli si ruppero le maniglie delle valigie, tutte nello stesso momento. Lui imprecò.
Ci fu un ultimo sussulto, un attimo appena, mentre il tassista aspettava: un abbraccio, uno sguardo. Il vento freddo del New England. Se lo tirò dietro mentre chiudeva la portiera della vettura. Lei lo guardò ancora e poi si girò e andò via. Il taxi si tuffò nel traffico. Eccola Veronique, che si faceva forza mentre camminava a ridosso del muro bianco del dormitorio, con le mani nel cappotto lungo scuro e la figura un po’ incerta, da lontano, una sagoma tra le altre. Will la cercò da dentro la macchina: perché non girava il capo verso la strada, verso di lui? Veronique… ehi, guardami… Successe. I loro occhi si incontrarono ancora un istante, lei lo vide e lui agitò la mano sorridendo. Lei fece lo stesso. Poi il taxi girò nel viale, e Will tornò a guardare avanti.
Allora successe un’esplosione, come una vampata dentro il cuore, un sussulto di angoscia e di vita, di rimpianto, di furia; e dolore, dolore, dolore bruciante. Allora capì quanto contassero, dietro all’umorismo un po’ distaccato e alle battute e agli scherzi, dietro all’immagine sarcastica e disimpegnata che si era dato, quanto contassero ancora le emozioni e le persone. Si sentì uguale a tutti gli altri ora.
Tommaso uscì da Banana Republic, il grande negozio multipiano affacciato sulla Fifth Avenue. Pacchi e pacchetti e sacchetti e il caos di New York a Natale. Il cielo era azzurro scuro, e sì che domani su tutta la East Coast doveva nevicare, secondo il meteo. Chi se ne importa, si disse. Domani sarò sull’aereo. Dopodomani, a casa, in Italia.
La mattina seguente, prestissimo, prese l’autobus dalla Penn Station, con Giulia e Marco, che erano venuti a trovarlo a Boston e coi quali era sbarcato a New York sette giorni prima. Quando il veicolo si mosse dalla stazione e il contorno netto di Manhattan prese forma al di là delle finestre… fu allora che Tommaso ebbe finalmente percezione che l’America lo stava salutando. I quattro mesi all’università si chiudevano come un piccolo scrigno. Allargò un mezzo sorriso al ricordo disordinato delle lezioni, degli sciatti compagni di stanza, del portiere pakistano del dormitorio, con le mani unte e l’inglese incerto. Una carrellata veloce come i personaggi di un film di Truffaut. Beh, addio, si disse. Nelle orecchie aveva già Maroon 5, l’iPod sulle ginocchia, Giulia che gli riposava accanto. Il bus correva sulla grande autostrada. Gli Usa stavano ormai tra due discrete parentesi.
La giornata di Will passò lentamente. Sull’autobus, in mezzo ai boschi dorati del Connecticut, poi negli infiniti serpenti autostradali che circondano New York, e infine a casa, a Philadelphia. Suo fratello dormiva già, dovette fare tutto a luce spenta, silenziosamente infilarsi sotto le lenzuola, nel buio, da solo. Pensò a Boston e a tutto quanto, a Veronique. Qualcosa era rimasto in sospeso, una frase a metà, un sospiro, un’allusione…
Sentì un’unica fitta di autentica disperazione, e restò assediato dal male per una, due, tre, quattro ore. Una domanda gli martellava nella testa – Cosa sarà di me ora? – e un volto davanti agli occhi, quello di lei.
Doveva vederla. Ancora una volta. Domani, la vigilia di Natale, anche se l’aereo di lei partiva alle nove della sera. Trovò quiete nel pensiero che l’avrebbe rivista. E terrore al pensiero di affrontare i suoi sentimenti. Nel mezzo della tempesta, per fortuna, si addormentò.
Per Tommaso il tradimento venne all’aeroporto di Boston: niente volo per l’Italia, c’era da aspettare domani, il venticinque. Natale in volo! Gli altri invece potevano partire, viaggiavano con un’altra compagnia. In un momento odiò l’aeroporto, gli amici, Boston, l’America. Voleva tornare a casa. Si sentì una specie di ostaggio.
Decise di dormire in un albergo in centro per la notte della vigilia. Era uno di quei posti per uomini d’affari di passaggio, caro, elegante, impersonale. Doveva strisciare una carta per attivare l’ascensore e al posto del receptionist c’era un computer che stampava la ricevuta al momento di lasciare l’hotel. La sua stanza era di un lusso sofisticato e artificiale, legno scuro e TV al plasma. Nonostante il sistema di riscaldamento, Tommaso ebbe un brivido.
Will arrivò alla South Station alle quattro del pomeriggio, dopo altre otto estenuanti ore di viaggio sullo stesso percorso del giorno prima. Aveva provato a chiamare Veronique per tutta la durata del tragitto, ma il cellulare americano di lei era già spento, forse per sempre. La ragazza stava sicuramente finendo i bagagli, diretta all’aeroporto.
Smontò dal bus in velocità, corse a slalom nella grande hall della stazione, uscì e chiamò un taxi. Di nuovo a Boston. La città lo accolse ancora, paziente, non sembrava sorpresa nel vederlo, dopo solo una trentina di ore. Le facciate dei palazzi vittoriani in pietra rossastra, le ghirlande di Natale sulle porte, giovani col paraorecchi che portavano a spasso il cane nel Public Garden, e, sopra a tutto questo, il cielo che andava scurendosi: era Boston, col suo fascino nordico, cortese e impassibile.
Cominciava già a nevicare quando il taxi giunse nel campus studentesco. Si fece lasciare davanti alla porta dell’appartamento di Veronique. Cosa doveva dirle? Non lo sapeva nemmeno lui. Aveva provato a fare progetti, si era esercitato in spiegazioni e cose intelligenti e sensate. Ma niente. C’era solo lui e il suo desiderio di un ultimo contatto, di un saluto, che lo aveva spinto fin qua. Suonò alla porta. Aspettò qualche secondo ma non successe niente. Aspettò ancora, suonò ancora… aspettò. Il timore che lei fosse già in taxi, diretta all’aeroporto. Via, di corsa, presto! Si girò verso la strada in cerca di un altro tassista. Ma la porta si aprì all’improvviso. Lei.
«Ehi!» fece Veronique, gli occhi spalancati. Aveva un maglioncino lilla, la sciarpa già al collo, un’aria come di uno che vede un animale esotico. «Tu sei pazzo», fece a tempo a dire con un sorriso. Will si avvicinò. «Volevo dirti…» I loro corpi si toccavano già, poteva sentire le braccia di lei attorno ai fianchi, il suo petto tiepido premere contro la sua pancia. «Volevo dirti…», contro il portone, a Boston, prima di Natale, ora e mai più. Si baciarono. La neve cadeva.
Nella stanza accanto a quella di Tommaso una coppia faceva sesso. I due tizi erano rumorosi, per quanto alzasse il volume del televisore e cercasse di concentrarsi sul sito internet che aveva di fronte agli occhi. Gli fece schifo stare a sentirli la notte della vigilia. Vincendo una pigrizia antica, indossò giacca sciarpa e scarpe pesanti e uscì. Nevicava fitto fuori, le strade erano bianche. Silenzio di tomba. Tra non molto sarebbe stata mezzanotte. Non l’aveva mai vista così, Boston. Alzò lo sguardo alle finestre dei palazzi e le vide illuminate. Per la prima volta, Tommaso ebbe un balzo dentro. Non gli era mai capitato, nei tanti Natali italiani con la famiglia, coi parenti e la voce ovattata di Nat King Cole dallo stereo in salotto: capì di essere solo. Qui era solo, a Boston, a Natale – eppure la sua condizione aveva qualcosa di più ampio e profondo. In quel momento incerto, mentre la sua vita gli si stringeva nelle mani come un gomitolo, e anziché giovane e pieno di avventure era uomo, era pianto, era in piedi davanti al futuro, la sua vera solitudine venne fuori all’improvviso, tutta intera, muta, pesante. Sono spoglio di tutto, si disse. Mi resta solo questo tenace attaccamento alla vita. Una rivolta contro l’annichilimento. L’entusiasmo per le cose nuove. L’affetto per il passato. Odori, ricordi, sensazioni. L’ambizione di farli arrivare a qualcun altro, attraverso lo strumento imperfetto delle parole.
Camminò tanto, attraversò la Boston University deserta, e alla fine, chissà come, approdò alla Marsh Chapel, la chiesa del campus, quella dove solo un mese prima si era fermato ad ascoltare un amico che cantava motivi barocchi e romantici col coro universitario.
Le porte erano aperte; da dentro proveniva una luce leggera. Un piccolo albero con bianchi lumini era stato allestito sulla destra. In testa alla navata stavano uomini di diverse confessioni cristiane, c’era un prete cattolico e una religiosa vestita con un abito bianco, sicuramente di una qualche chiesa protestante. Mentre Tommaso sbirciava dalla corta scala in pietra che stava fuori dall’ingresso un individuo gli passò accanto ed entrò con decisione, prendendo posto in uno degli ultimi banchi. Aveva una giacca imbottita rossa e argento e jeans e scarpe grosse. Era uno del suo dormitorio, un americano. Non sapeva il suo nome. Non lo conosceva se non per avere condiviso con lui un paio di viaggi dentro al vecchio ascensore. Niente più. Cosa ci faceva qua, ora?
Entrò. Si sedette accanto al ragazzo. Si salutarono con un cenno. La veglia proseguì con una veloce predica, e qualche preghiera. Le candele profumavano. Era bello.
Poi stettero tutti quanti in piedi, a cantare “Silent Night”. L’organo li accompagnò per un pezzo, poi smise del tutto, e ci furono solo le loro voci. Will pensava al Natale e a Veronique. Tommaso cantò con gli altri, da quanto era che non lo faceva? Fu così che mentre cantava si ritrovò in una strana sensazione.
I due ragazzi guardarono l’altare mentre “Silent Night” si concludeva quasi sottovoce; poi a mezzanotte meno dieci tutto finì, e lentamente la gente uscì dalla chiesa. Tommaso e Will camminarono un poco insieme.
«Di dove sei?»
«Philadelphia».
«Ci sono stato questo novembre, è bella».
«Uhu… non è male, sì».
Parlarono di piccole cose, senza pretese. La neve aveva smesso di scendere. Era mezzanotte. Senza saperlo, Will e Tommaso avevano pensieri comuni. Tutto si è scoperto, si dissero, e tutto è ancora da cominciare.
Wednesday, December 27, 2006
Un racconto di Natale
Pubblicato da
francesco c.
a
12:01 PM
2
commenti
![]()
Friday, December 08, 2006
Tiramisù
E' il momento di pubblicare qui la mia ricetta del Tiramisù. Per curiosità, ho dato un'occhiata con Google tra le diverse indicazioni culinarie italiane che appaiono su internet. Poveri noi. La cosa che sembra appassionare di più gli autori delle ricette è la pronta cementificazione del povero Tiramisù con chili di mascarpone (fino a 600 g una porzione per quattro! e chi li porta via gli ospiti?) e strati infiniti di Savoiardi, tra l'altro rigorosamente asciutti, una specie di muraglia cinese.
La mia ricetta non è mia, nel senso che, come sempre avviene, è debitrice di altre ricette. Si limita a rimescolarle un po' e ad aggiungere qualche pignoleria. L'idea di base è che il Tiramisù debba essere un dolce "bagnato", che non obblighi quasi a masticare; che abbia un colore e un carattere, nel senso che l'uovo si deve sentire; che non si lasci sopraffare dal gusto del caffé.
Un buon 70% di quanto scritto viene dalla brava signora Malvina P., prima (e unica) insegnante di cucina in un corso che abbia frequentato; un 20% da mia madre, che come tutti sanno cucina da Dio; un 10% è fatto dal sottoscritto, non di più.
Prendete una bacinella larga. Sbattete bene 120 grammi di zucchero con quattro tuorli d'uovo finché non si amalghimino del tutto. Aggiungete progressivamente 250 grammi di mascarpone e amalgamate evitando i grumi. Montate a parte 200 ml di panna, circa 4/5 della confezione classica. Aggiungete e mescolate con cautela. Montate a parte 3 chiare d'uovo scarse a neve. Aggiungetele al resto e mescolate con cautela. Intanto, preparate il caffé, due o tre moche almeno, piuttosto leggero. Versatelo in un piatto fondo e aggiungete un paio di cucchiaini di zucchero. Passate uno dopo l'altro i Savoiardi nel piatto, facendo attenzione che si bagnino completamente, ma che non si rompano. Disponeteli in una terrina larga e dai bordi bassi in un solo strato. Se il caffè non basta, fate un'altra moca, e così via. Quando la terrina è coperta dai Savoiardi, aggiungete la crema fino all'orlo. Spolverate con cacao amaro. In frigo per almeno quattro ore.
Pubblicato da
francesco c.
a
7:05 AM
1 commenti
![]()