Aveva cominciato con l'endorsement per la candidata democratica in Missouri Claire McCaskill, in cui appariva per quasi un minuto afflitto dal tremore tipico dei malati di Parkinson, invitando a votare contro il rivale repubblicano che si oppone alla ricerca sulle cellule staminali.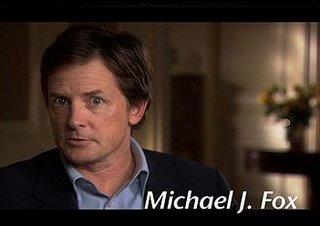 Michael J. Fox, l'eroe degli 80s reaganiani, dei Ritorno al futuro parte I, II e III, degli skateboard e delle Tv series ultraconservatrici, è in lotta contro la malattia da un decennio, scomparendo dagli schermi, ma è ancora giovane, e certo l'immagine che presenta in questi giorni al pubblico è molto forte (se non si vuole credere all'accusa che gli è stata rivolta di avere esagerato notevolmente il tremore per dare maggior pathos allo spot elettorale).
Michael J. Fox, l'eroe degli 80s reaganiani, dei Ritorno al futuro parte I, II e III, degli skateboard e delle Tv series ultraconservatrici, è in lotta contro la malattia da un decennio, scomparendo dagli schermi, ma è ancora giovane, e certo l'immagine che presenta in questi giorni al pubblico è molto forte (se non si vuole credere all'accusa che gli è stata rivolta di avere esagerato notevolmente il tremore per dare maggior pathos allo spot elettorale).
Ora Fox ha firmato un nuovo ad per il candidato democratico al senato Ben Cardin, del Maryland, ripetendo le stesse accuse contro l'opponente Michael Steele: "George Bush and Michael Steele would put limits on the most promising stem cell research. Fortunately, Marylanders have a chance to vote for Ben Cardin. Cardin fully supports life-saving stem cell research. It's why I support Ben Cardin". L'idea che i democratici vogliono far passare è di una scelta tra civiltà e barbarie, tra ragione e dogmi religiosi, tra libertà e veti.
Ma Cardin non aveva fatto i conti con un piccolo particolare: Monica Turner, pediatra, malata di sclerosi multipla, che ha risposto al messaggio democratico con un altro ad, severo ma discreto - e anche più dignitoso. "Ben Cardin sta attaccando Michael Steele con spot falsi e di cattivo gusto. Sta usando la vittima di una terribile malattia per terrorizzare la gente solo per il suo personale tornaconto elettorale. Cardin dovrebbe vergognarsi".
Ma non basta. Steele è a favore della ricerca staminale, a patto che non distrugga gli embrioni. E la Turner spiega: "c'è qualcosa che dovreste sapere a proposito di Michael Steele. Egli sostiene la ricerca sulle cellule staminali, e si prende cura profondamente di coloro che soffrono per le malattie. Come lo so? Sono la sua sorella minore. Ho la sclerosi multipla, e so che lui si prende cura di me".
Saturday, October 28, 2006
Ancora ads nella campagna per il midterm. Ma stavolta i democratici inciampano sulle staminali
Pubblicato da
francesco c.
a
11:19 PM
1 commenti
![]()
Sunday, October 22, 2006
La sfida elettorale in Massachusetts. Toni postmoderni e un po' surreali. E gli "ads" si rispondono a vicenda
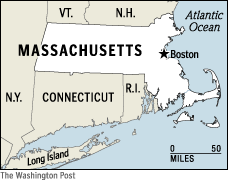 A poche settimane di distanza dalle midterm elections, il partito repubblicano, che tutti i sondaggi danno nettamente indietro rispetto al contendente democratico, sta reindirizzando i propri finanziamenti ai candidati locali per una campagna mirata. Il GOP punta ora a salvare il salvabile, dove la sfida con i democratici si gioca sulla linea di pochi punti percentuali, mentre i fondi vengono sottratti ai contesti dati ormai per persi. Il caso Fowley, il consulente repubblicano di Washington costretto alle dimissioni da ogni incarico dopo la pubblicazione di email in cui circuiva ragazzini sedicenni che studiavano per entrare nello staff del Congresso, sembra avere affondato gli sforzi compiuti all'inizio di settembre da Bush, quando i repubblicani avevano brillantemente recuperato punti percentuali dopo una serie di accattivanti discorsi del Presidente.
A poche settimane di distanza dalle midterm elections, il partito repubblicano, che tutti i sondaggi danno nettamente indietro rispetto al contendente democratico, sta reindirizzando i propri finanziamenti ai candidati locali per una campagna mirata. Il GOP punta ora a salvare il salvabile, dove la sfida con i democratici si gioca sulla linea di pochi punti percentuali, mentre i fondi vengono sottratti ai contesti dati ormai per persi. Il caso Fowley, il consulente repubblicano di Washington costretto alle dimissioni da ogni incarico dopo la pubblicazione di email in cui circuiva ragazzini sedicenni che studiavano per entrare nello staff del Congresso, sembra avere affondato gli sforzi compiuti all'inizio di settembre da Bush, quando i repubblicani avevano brillantemente recuperato punti percentuali dopo una serie di accattivanti discorsi del Presidente.
Ma non ci sono solo i rappresentanti in parlamento. A novembre gli Statunitensi andranno alle urne anche per eleggere i governatori dei singoli Stati. In Massachusetts la sfida è dura, in questo stato ultraliberal l'attuale reggenza è repubblicana, un po' come succede a New York: apparenti paradossi di quel pragmatismo del buongoverno che porta gli Americani a tenere faccende locali e nazionali in due sfere rigorosamente separate. I democratici sono dati in discreto vantaggio, ma l'impressione è che la sfida sia ancora aperta. Candidata dei repubblicani è Kerry Healey, lieutenant governor, cioè vicegovernatrice uscente, biondina, ordinata, elegante con sobrietà, sembra uscita da una riunione di condominio, efficienza e discrezione. Deval Patrick corre per la sinistra. Molto, molto classico e politicamente corretto. Nero, avvocato, giovane e attraente, immagine soft da bravo ragazzo un po' idealista, classica storia di povere origini e classici sacrifici e classica affermazione personale, slogan logoro ma sempre piuttosto efficace - insieme possiamo, together we can (e non importa se la candidata dei Verdi dice che glielo hanno preso in prestito, senza chiedere, ovviamente).
Candidata dei repubblicani è Kerry Healey, lieutenant governor, cioè vicegovernatrice uscente, biondina, ordinata, elegante con sobrietà, sembra uscita da una riunione di condominio, efficienza e discrezione. Deval Patrick corre per la sinistra. Molto, molto classico e politicamente corretto. Nero, avvocato, giovane e attraente, immagine soft da bravo ragazzo un po' idealista, classica storia di povere origini e classici sacrifici e classica affermazione personale, slogan logoro ma sempre piuttosto efficace - insieme possiamo, together we can (e non importa se la candidata dei Verdi dice che glielo hanno preso in prestito, senza chiedere, ovviamente).
Fa un po' ridere la sfida in Massachusetts, che in America è uno degli stati più ricchi, più sicuri, più socialmente tutelati, più intellettualmente sofisticati. Fa un po' ridere una sfida in cui ciascuno ha giocato a chi coccola di più gli elettori. Non dicono: vi abbasso le tasse, no, vi abbasso ancora le tasse. E nemmeno: fermiamo il crimine, ma fermiamo alcuni deplorevoli episodi di criminalità. Probabilmente l'elettore medio in Massachusetts si chiede perchè dovrebbe ancora esserci crimine. La gente è talmente sicura della propria inclinazione progressista che persino la candidata repubblicana si presenta dicendo: "anch'io sono per la ricerca sulle cellule staminali embrionali, anch'io sono per l'aborto", preoccupata di prendersi la propria patente di laicità, di non perdersi il voto dell'80% di democrats, mentre da sinistra si risponde con più diritti agli immigrati e energie alternative. Così, però, si rischia di annacquare la sfida. E allora, la differenza la si cerca nei candidati.
La battaglia degli "ads", degli spot elettorali, è un buon esempio. Esauriti i noiosi argomenti sugli sgravi sulla benzina, Healey è passata all'attacco su temi strettamente personali, citando alcune dichiarazioni in cui Patrick difendeva Ben LaGuer, un tizio condannato ad anni di prigione per molestie e violenze sessuali su una donna di cinquantanove anni, dicendo che era "eloquent and thoughtful". Lo slogan, molto forte, che chiude lo spot ("Deval Patrick, he should be ashamed, not governor") stride un po' con l'aspetto familiare e rassicurante della Healey, e le note al pianoforte e gli interni eleganti che accompagnano i suoi messaggi. Ma in un punto la Healey ha fatto breccia: il suo contendente ha voluto offrirsi agli elettori con una storia personale di ascesa e fatica. Ha citato lungamente la propria carriera, i propri studi (guess what... Harvard, naturalmente). Ha portato Clinton in centro a Boston per dire che di Patrick, sì, ci si può fidare. Ok, se l'obiettivo deve stare su di lui, si sono detti i repubblicani, divertiamoci un po'. Patrick si è difeso. Lo ha fatto in un modo che solo qui può funzionare, e cioè con puntiglio quasi maniacale. Alla solita lagna democratica - poveri vecchietti che si chiedono se con i repubblicani potranno ancora permettersi di vivere nella propria casa - ha affiancato nuovi ads con risposte piccate all'attacco della Healey. Ha chiamato a testimoniare Martha Coakley, compassata procuratrice del Middlesex, per dire che i repubblicani sanno solo offrire "negative ads". E lo stesso ripete un altro ad, "dopo anni di malgoverno... dai repubblicani solo negative ads". Il Boston Globe commentava sarcastico: "nuovo spot di Patrick, che accusa gli spot di Healey". Cioè: non c'è più niente di cui parlare, parliamo della campagna stessa. Molto postmoderno.
Patrick si è difeso. Lo ha fatto in un modo che solo qui può funzionare, e cioè con puntiglio quasi maniacale. Alla solita lagna democratica - poveri vecchietti che si chiedono se con i repubblicani potranno ancora permettersi di vivere nella propria casa - ha affiancato nuovi ads con risposte piccate all'attacco della Healey. Ha chiamato a testimoniare Martha Coakley, compassata procuratrice del Middlesex, per dire che i repubblicani sanno solo offrire "negative ads". E lo stesso ripete un altro ad, "dopo anni di malgoverno... dai repubblicani solo negative ads". Il Boston Globe commentava sarcastico: "nuovo spot di Patrick, che accusa gli spot di Healey". Cioè: non c'è più niente di cui parlare, parliamo della campagna stessa. Molto postmoderno.
Così la politica ripiega su se stessa qui in Massachusetts, con sfumature un po' surreali. Funzionerà?
Pubblicato da
francesco c.
a
7:48 PM
1 commenti
![]()
Saturday, October 14, 2006
L'insostenibile leggerezza dei nostri parlamentari
Il Darfur è in Libano, no, è uno stile di vita, Mandela sta in Brasile, è una figura dibattuta, è un avvocato, Guantanamo è in"Afagnistan", anzi, in Iraq, la Consob, la Consob... che cos'è la Consob?
Spassosissimo e doloroso articolo della Rodotà, che riprende un quiz delle Iene: clicca qui.
Non è demagogia, nichilismo antiparlamentare, è l'allegra ignoranza - bipartisan - dei nostri politici.
Pubblicato da
francesco c.
a
6:59 AM
0
commenti
![]()
Wednesday, October 11, 2006
New York.

Chinatown, mezzogiorno. Metto piede sul marciapiedi grigio d’asfalto e di sporco. Il bus ci vomita in mezzo alla via, senza riguardo. E’ Canal Street, e sembra un canale davvero, un canale veneziano intruppato di turisti, di venditori ambulanti, di macchiette, di popolaccio. La via è lunga, segue le dolci colline che in un tempo remoto segnavano coi loro declivi Manhattan e che ora soffocano sotto eserciti di taxi giallo scuro. Le puoi vedere se guardi in lontananza, verso un improbabile orizzonte: perché New York è una città dal respiro verticale, non è facile spostare gli occhi dai palazzi che crescono verso l’alto. Con la valigiona mi faccio strada in mezzo alla folla, “the folks” come dice Sally, l’amica della Anna. Mi tornano in mente ora, le parole snob dell’elite ebraica newyorkese. Spinte, grida, biancheria sui balconi, scritte bilingue – ma anche monolingua, perché no, cantonese ovviamente, a Manhattan ormai vivono trecentomila cinesi, chi li ferma più. Solo un secolo e uno sputo fa erano gli ebrei quelli che si accalcavano negli slums della midtown, che sbiascicavano il loro yiddish mentre il jazz fermentava dentro al crogiolo delle razze e delle culture.
“No Francesco, non è il meltin’ pot – mi ha rimproverato Carlos, ecuadoregno, collega alla BU – quello è un concetto novecentesco, vecchio, superato”. Altro che crogiolo, al massimo ora ci si fa una pizza. “Sì, l’American Pizza. E’ il nuovo modello di integrazione statunitense”. Che sarebbe? “C’è una pasta comune, una base uguale per tutti, e poi ognuno aggiunge quello che ha, senza cancellare le identità rispettive – e i rispettivi odori – solo sommandoli”. Come una pizza americana. L’integrazione del Ventunesimo secolo insomma è più che altro una convivenza neutra e acritica, una coabitazione senza contaminazioni, tollerante, molto competitiva.
Il concetto mi piace, Carlos ha ragione, guarda come cambia la città ora che finalmente esco esausto da questa Chinatown sozza e puzzolente. Sbarco in Upper East Side, il quartiere dei vip mi dicono, ma l’ostello sulla mappa è un po’ troppo Upper, quasi all’angolo di Central Park; pochi vip dunque, semmai un residuo di borghesia ormai in fuga da questi lidi, e dignitosi isolati di verde e di grigio e di rosso scarlatto. Molti neri per le strade, poco più in là cominciano Harlem e Bronx, un altro mondo, a me sconosciuto come alla maggior parte dei cittadini del centro.
La mattina era cominciata con un sussulto drammatico. La sera prima, a Boston, meeting in birreria, tutti insieme noi del gruppo degli studenti internazionali: “allora, pronti alla fermata della metropolitana alle sette precise, anzi no, facciamo sette e cinque, così abbiamo il tempo di raccattare una mezza colazione in mensa”. L’autobus per NYC partiva alle otto, il tempo di attraversare la città con la T line (la lentissima metropolitana bostoniana) e di essere in stazione puntuali. Mi raccomando, mi raccomando, ci eravamo ripetuti vicendevolmente.
Risultato: alle sette e dieci del mattino arrivava Lorena, alle sette e quindici Carlos ma si dimenticava il biglietto in camera, e tornava a prenderlo. Alle sette e venticinque spuntava Buket, di Solenn nessuna traccia, poi apprenderemo che era partita alle sei e cinquantacinque col terrore di perdere il bus. Alle sette e quaranta la mia sveglia esausta suonava un’ultima volta, mi sveglio di soprassalto, vedo l’ora e impreco, salto su dal letto come una molla, mi infilo la maglia e esco dalla stanza di corsa senza neanche fare pipì, col trolley che mi rumoreggia dietro come un vecchio vagone. Nella hall del palazzo decido di fare l’upper class man e chiedo al portiere di chiamarmi un cab, please. Perso l’autobus: il taxista corre veloce ma non abbastanza. Lorena Carlos e Buket sono già in viaggio, nervosissimi. Hanno lasciato il mio biglietto allo sportello della compagnia, per convincere le signorine hanno inventato una storia drammatica di coincidenze perse e di guasti alla metropolitana. Io arrivo e rovino tutto: “ah ah, scusatemi, quando non si sente la sveglia…” Prendo il bus delle otto e mezza. Appena si accendono i motori e il veicolo fa cinque metri mi arriva un sms da Miguel, il grande assente: “wait 4 me i’m coming”. Bye bye, Miguel. Che disastro.
Siamo arrivati a New York alla spicciolata, come un’allegra e discreta invasione, ovviamente del tutto inosservata in un’isola che ogni giorno di invasioni ne sopporta a centinaia, migliaia. Abbiamo guardato tutto il possibile in soli tre giorni, scivolando dalla upper alla lower Manhattan, dalla quinta strada a Soho, dall’Empire State a Ellis Island, un giro molto turistico, così, per farci un’idea. Io ho un’impressione netta, e cioè che New York e l’America vivono due esistenze separate, sono come una sfera che ne contiene un’altra, o come gli anelli delle olimpiadi che si intersecano ma non si tangono. La grande nazione americana ha fornito solo la pista di lancio per una città che è un sedimento comune dell’Occidente, del mondo, di tutti noi. Svettano le bandiere a stelle e strisce sopra l’entrata dei grattacieli, ma chi se le fila, New York guarda a se stessa e al proprio mito meritato, alla propria epopea scintillante e polifonica, alla vocazione cosmopolita che la distingue dal severo e compassato New England al quale, ci tiene a ribadirlo, non appartiene. In autobus una vecchietta mi chiede da dove vengo: Italia, rispondo. E lei? “California”, fa. Sì, è sbarcata qua ventitré anni fa e non se n’è più andata. Quando parla di Manhattan le brillano gli occhi: “overwhelming”, che significa schiacciante, ma a lei piace, è schiacciante questa città che in un giorno ti offre tutto, che si apre come un grande pomo dorato. “The roughest city”, la città più rude, più sgarbata, aveva detto con un certo rimprovero Michael, americano del Tennessee – del dolce, languido, profondo Sud. E’ vero, a New York non ci sono le buone maniere del resto degli States, la gente parla veloce, è scettica e imperturbabile. Come mi scrive Anna, che la Grande Mela la conosce meglio dei newyorkesi: "è cinica, diretta, indipendente e incoerente... sporca, a volte puzzolente (8 milioni che vivono in un isola...!!!!), è simpatica e antipatica, è New York, dal barbone alla lady".
Sì, c’è un certo sadomasochismo in questi newyorchesi che si lasciano sedurre e schiacciare, che soffocano nel caos e nel traffico, ma anche nelle mostre, nei concerti, nelle parate.
E sopra a tutti, gigante, maestoso, Central Park…
Pubblicato da
francesco c.
a
7:47 AM
2
commenti
![]()
Friday, October 06, 2006
Università e community

E’ buffo, ma Boston mi suscita le stesse sensazioni di Padova. Stasera la giravo per conto mio, dopo la classe del pomeriggio. Ha quell’aria di familiarità propria delle città universitarie, le dimensioni ridotte, il tran tran studentesco con le consuete vagonate di studenti che si affannano su e giù per i marciapiedi tra una lezione e l'altra.
Al di là delle ovvie differenze, c'è una cosa che però Padova, anzi credo l'università italiana non ha, e che Boston invece, come le colleghe statunitensi, ci tiene a preservare: è la comunità studentesca, il campus, inteso più come condivisione della vita universitaria che come il luogo fisico dove trovano spazio le facoltà e i dormitori e le mense. Vita pulsante. Associazioni, siti web, dibattiti, giornali, competizioni, meeting, gruppi di lavoro, sport, sport - tanto sport - e immensi caseggiati che svettano su Commonwealth Avenue come alveari, come vivai, dove la gente dorme, mangia, beve, studia, scherza, piange, si riproduce. BU Today si chiama il sito "prima pagina" del campus.
L'università è prima di tutto un'esperienza, un'esperienza collettiva. Hai un goal - ognuno si porta dietro nello student status l'anno previsto di graduation, come dire, no perditempo - una potente rete di relazioni tutta online (http://bu.facebook.com) e una comunità più piccola, fatta da quelli del tuo piano, o, se vivi nelle luxury brownstones, da quelli del tuo palazzo. Soprattutto, questi sono i tuoi quattro anni per il futuro. Il primo è una macedonia, puoi fare di tutto, non devi scegliere, solo provare, sperimentare. Poi prendi una decisione. E gli altri tre anni si lavora. Tutti frequentano le lezioni, tutti partecipano alle discussion section, certe volte è una selva di braccia alzate. Siamo qui, e "facciamo bene", come dicono gli Americani. Per noi come individui, per noi come squadra. Efficiente e unita. Se perdi tu, non perdi da solo, è la squadra che perde.
L'università americana avrà i suoi difetti, ma ha capito una cosa importante: l'obiettivo è farti uscire dandoti qualcosa. Forza, grinta, preparazione, voglia di fare, voglia di far bene. Saremo più colti, più profondi, più complessi noi Italiani: ma certo che a pensare a come io e i miei colleghi ci affanniamo per conquistare il trenta e lode, alle nostre interrogazioni fatte sbobinando le parole del professore, alle riverenze e gli sdilinquimenti, e poi ai laureati in lettere che riempiranno scaffali del supermercato per il resto della loro vita, che con la specializzazione in beni culturali compileranno il depliant turistico del loro paese... be', mi spiace, ma mi viene un po' da ridere. E da piangere.
Pubblicato da
francesco c.
a
8:15 AM
1 commenti
![]()
Good Day, Mate!

saturday morning brunch
il sottoscritto, Giorgia, Miguel, Solenn, Carlos
Harvard Campus, con Lorena e Miguelito
Charles Bridge! Da sinistra, Alex, io, Buket, Giorgia, Lorena, Solenn, Mathieu
io e Carlos al Boston Common
oohh, nouvelle cuisine, les champs elysées, maurice chevalieee-eer!
Pubblicato da
francesco c.
a
7:45 AM
1 commenti
![]()
Thursday, October 05, 2006
"Bush è un fascista?"
Class discussion, questo pomeriggio. Ho ammirato il buon senso anglosassone, ancora una volta. L'epicentro è, come al solito, il corso di Comparative Fascism, la mia finestra aperta sulla politica americana, il barometro di quell'America color blu cobalto che alle scorse elezioni qui a Boston ha regalato a John Kerry il 78% dei voti. Prendi Sean, per esempio. Biondino, magrissimo, spigoloso, occhialoni, sulla t-shirt ha una spilletta "ho votato" (alle primarie, si intende), su internet aderisce a: "Responsible Gun Control", "People for a Democrat Majority this November", "I Support Gay Marriage Because Marriage is About Love", "Keep the Estate Tax", "Illegal Immigrants are People Too", "Students Against Hitler". Prendi David, very liberal si autodefinisce, prendi Katie, che supporta la campagna per la rielezione del governatore democratico del suo stato, il Wisconsin, very liberal pure lei. Prendi Zatlin, il professore, probabilmente ebreo, sicuramente leftist. Al termine della lunga lezione lancia il sasso: dopo tutto quello che avete letto e dibattuto su nazismo e fascismo, che Bush vi piaccia oppure no... lo considerate un fascista?
Mi corre un brivido giù per la schiena, penso all'Italia, a Padova, ai cineforum sull'involuzione autoritaria del capitalismo, al prof. Lanaro che in campagna elettorale fa gli appelli di voto al termine della lezione, "votate come dei coglioni!", alle scritte oscene sui muri dei cessi: antifascismo militante, parole poche mazzate tante. Penso alle risposte viscide che darebbero i nostri docenti - "ecco, forse non è esattamente definibile fascismo, ma certo è innegabile che alcune caratteristiche...", "il fascismo del terzo millennio, travestito da capitalismo...", "figlio dell'America profonda e fondamentalista..."
No, no, no. "Oh, definitely, no". Una sfilza di no dagli studenti di sinistra americani. Smorfie di disapprovazione, di fastidio. Come davanti a una domanda tendenziosa, poco seria. Argomenti: la democrazia americana non è in pericolo, i repubblicani non vogliono il monopolio dell'informazione, non usano la violenza come strumento della lotta politica, non pensano a mettere in galera i propri avversari. Anche: "tutti i media criticano il presidente, faccio fatica a sentire una voce favorevole". Sono contento di voi, ragazzi, dice il prof.: sono del tutto d'accordo, Bush ci può non piacere, ma NON è un fascista, checchè ne dica Noam Chomsky. Ricordiamocelo. Non scherziamo con la storia.
Ecco, è qui il cuore di questa grande nazione, nel buonsenso. Voteranno democratico o repubblicano i cittadini degli Stati Uniti, alle prossime elezioni del mid-term, non importa. United we stand: non è solo un vecchio motto, un adesivo sul finestrino posteriore delle auto...
Pubblicato da
francesco c.
a
4:35 AM
5
commenti
![]()
Tuesday, October 03, 2006
Diario di viaggio / Laura
Laura. Nel complesso non è male. E’ una questione di come la prendi, e di come lei decide di prenderti. Se accetti il suo nervosismo impersonale e le sfuriate episodiche le cose possono funzionare. Chiudi un occhio, chiudili entrambi, sorridi. A me piaceva che con quel suo modo brusco e sfrontato portasse a galla le tensioni e i rancori e in questo modo li esorcizzasse, li spazzasse via con una manata. Era un residuo di vitalità in una gioventù priva della voglia di litigare. Il primo scontro lo abbiamo avuto un paio di settimane dopo l’arrivo. Più che uno scontro è stato un fulmine a ciel sereno, un temporale estivo. Così violento, così inutile, così passeggero. Lei si è arrabbiata per la questione del ristorante, della colletta per la festa, del fatto che, insomma, del… a dire il vero non sono sicuro di aver capito perché. Quando gliel’ho chiesto si è arrabbiata ancora di più e mi ha detto che “Francesco, proprio non capisci”. Solleticava la mia insicurezza con le donne, quel senso ruvido di inadeguatezza, di sentirsi fuori posto. Ho pensato che ce l’avesse con me, che fosse qualcosa di personale. Ma non era così. Quando gridava gli occhi le si arrossavano, vedevo che aveva voglia di piangere. Poi mi è venuta a cercare, facciamo pace, ha detto. Era chiaramente una valvola di sfogo, una breccia di rabbia e di rivolta, che si è aperta in una città che, forse, non le è mai piaciuta.
Boston è troppo fredda, dice. "La gente non ha davvero voglia di fare amicizia, sono solo molto gentili”. Lei l’ha presa in modo strano, questa trasferta americana, come una parentesi di distrazione, un’evasione un po’ disordinata. Lo dice: "è la mia terapia". Chissà.
Da quando è arrivata ha avuto tre o quattro uomini nel suo letto. Con uno ci ha fatto l’amore. No, no, che amore, sesso, solo sesso: “io l’amore lo faccio quando ci metto il cuore”. Uno solo, un californiano. Lei aveva bisogno di un po’ di divertimento, lo ha conosciuto in metropolitana, hanno bevuto e sono andati a letto insieme. Poi lui è scivolato via, quando sui rami degli ippocastani di Bay State Road hanno cominciato a cantare gli uccelli e la via ha preso contorni più definiti, mentre il cielo schiariva. A lei non è piaciuto molto, ma non importa, va bene così.
E gli altri? Amici, dice. Ci hanno provato? Sì, tutti, dice. Lei c’è stata? No, dice. Non è quel tipo di ragazza. Erano tutti residui di feste e bevute, ospiti di una notte che passavano per la stanza-ostello e che lei ha voluto non lasciare sul pavimento. Ma hanno solo dormito, e quando allungavano le mani, “non è proprio il caso”, diceva Laura; e loro, nel buio, si giravano dall’altra parte, rassegnati. Le piace fare la sorella, “fratello” e “sorella” sono parole che usa spesso per magnificare le sue amicizie veronesi. Ci crede, anche se esagera. Suo papà se n’è andato in modo brusco, non nel senso che è morto, nel senso che l’ha lasciata là, sulla strada, o quasi, con un fratellino e una madre fragile. Lei si è dovuta reinventare. E i suoi amici sono diventati un nuovo nucleo, una famiglia allargata. Fratelli e sorelle. Come l’hai presa? Cosa, risponde. Di tuo padre… Ah, dice, me lo sono lasciato alle spalle. Non me ne importa più niente. Sto bene ora. E’ semplice, lui è un bastardo e non ci merita. Ma noi andiamo avanti benissimo senza di lui.
Laura quando arriva alla mensa cammina svelta, nervosa. E’ alta, la si vede da lontano. Saluta tutti, ci tiene a sorridere sempre. L’altro giorno Daniel, lo spagnolo, le ha chiesto se stava meglio. Meglio? Meglio di cosa?, ha risposto lei. Meglio di ieri sera… dice lui. Laura ha sorriso impaziente: ma stavo benissimo ieri sera. Sto sempre bene, io! Oh, sì. Daniel è stupito. Sussurra: non mi sembra proprio… Ma Laura è lontana.
Pubblicato da
francesco c.
a
5:01 AM
0
commenti
![]()
